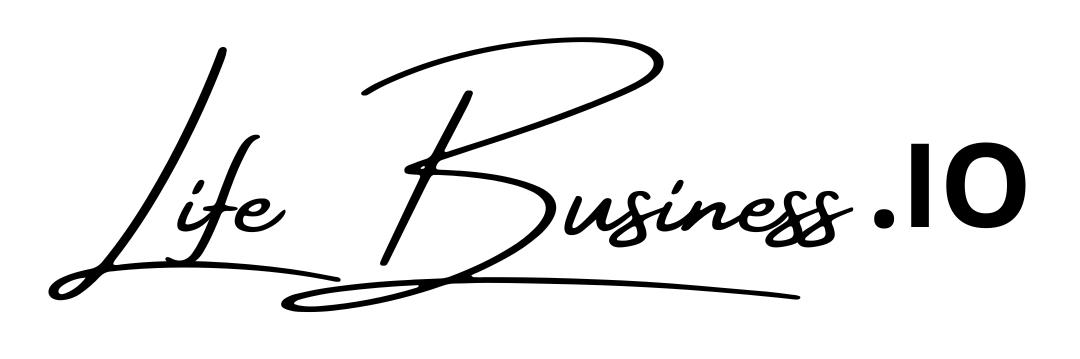G
li ambientalisti hanno ragione a denunciare le manovre delle multinazionali dell’economia del carbonio e dei loro lobbisti, volte a evitare l’adozione di accordi globali e vincolanti. Ma questa è solo la punta dell’iceberg: se il mondo sta impiegando così tanto tempo per reagire a un pericolo che tutti sanno essere imminente, è anche e soprattutto perché affrontarlo significa intervenire drasticamente sulle disuguaglianze esistenti tra le nazioni e al loro interno.
La dichiarazione di Rio del 1992 e il protocollo di Kyoto del 1997, affermando il principio della “responsabilità comune ma differenziata”, hanno accolto una vecchia istanza dei paesi più poveri: il riconoscimento della responsabilità storica delle nazioni più sviluppate. I paesi che hanno inquinato molto più degli altri dovrebbero impegnarsi in misura maggiore per ridurre le proprie emissioni e sostenere finanziariamente le iniziative di adattamento degli altri. Soprattutto perché sono riusciti a raggiungere il loro livello di prosperità soltanto sfruttando in maniera massiccia le risorse naturali, proprie e dei paesi che hanno colonizzato o con cui hanno commerciato, e bruciando quantità colossali di combustibili fossili. In questo modo le nazioni più sviluppate hanno emesso più di due terzi dei gas serra attualmente accumulati nell’atmosfera, pur rappresentando soltanto il 20% della popolazione mondiale. I numeri sono ormai ben noti.
[…] Questi confronti sono necessari se vogliamo attribuire a ciascuna regione del mondo la sua parte di responsabilità nella transizione. Possono però anche essere fuorvianti, poiché danno l’impressione che tutto si riduca a un problema di giustizia internazionale e di “quote” di emissioni da distribuire tra le nazioni. In realtà le emissioni di un individuo non sono tanto legate alla sua nazionalità quanto al suo specifico strato sociale. In termini di produzione di gas serra, uno statunitense ricco è più vicino a un africano ricco che a uno statunitense povero. Essendo un riflesso dello stile di vita, le emissioni sono strettamente legate al livello di reddito. Lo stesso ragionamento vale anche per la distruzione della biodiversità.
Se il mondo sta impiegando così tanto tempo per reagire al riscaldamento globale è soprattutto perché affrontarlo significa intervenire drasticamente sulle disuguaglianze esistenti.
Se scomponiamo le medie nazionali possiamo valutare fino a che punto le emissioni sono frutto di una “oligarchia climatica” che non conosce frontiere. Il 10% più ricco della popolazione mondiale è responsabile da solo di quasi la metà delle emissioni globali, mentre la metà più povera dell’umanità ne genera solo il 12%. E questa tendenza oligarchica non fa che accentuarsi nel tempo: più di un terzo dell’aumento delle emissioni riscontrato tra il 1990 e il 2015 è attribuibile al 5% più ricco della popolazione mondiale, distribuito tra i paesi poveri o emergenti e quelli ricchi.
Se concentriamo l’analisi sulla fascia più privilegiata della popolazione mondiale, su quell’1% corrispondente alla classe dei super ricchi, il divario si allarga in modo esponenziale. Questa piccolissima minoranza produce da sola molte più emissioni di carbonio della metà più povera del mondo. A livello individuale, i super ricchi nel corso della loro vita emettono tremila volte più carbonio rispetto al 10% più povero del pianeta. Tuttavia, è sempre questo 1% della popolazione mondiale ad avere registrato un’impennata del reddito e della ricchezza negli ultimi trent’anni.
Questa grande iniquità è riscontrabile in tutti gli Stati, compresi quelli in cui le disuguaglianze sociali sono relativamente limitate. In Canada, per esempio, le emissioni prodotte dal 10% più ricco sono nove volte superiori a quelle del 10% più povero. E più si sale nella scala del benessere, più il divario aumenta: in Francia, l’1% più ricco emette in media quaranta volte in più del 10% più povero e dodici volte in più della metà più povera della popolazione. Non è difficile spiegare questa differenza di responsabilità: tutto ciò che caratterizza il nostro stile di vita (abitazioni, elettrodomestici, cibo, viaggi, vacanze, tempo libero, beni di consumo ecc.) racchiude in sé una componente di energia, derivante dal processo di produzione o dall’utilizzo stesso di questi beni. Più aumenta il reddito, più cresce il consumo.
In realtà le emissioni di un individuo non sono tanto legate alla sua nazionalità quanto al suo specifico strato sociale.
Oltre a essere caratterizzati da una distribuzione iniqua delle responsabilità, i diversi paesi e gruppi sociali sono anche esposti in modo estremamente impari alle conseguenze dei problemi ambientali e delle catastrofi naturali. Ancora una volta, il fenomeno risulta evidente su scala mondiale. Quando parliamo di un aumento di 1,5-2 °C della temperatura globale, troppo spesso ci dimentichiamo che questo cambiamento generale colpisce le diverse regioni del mondo in modo assai differente. […] Le aree della Terra esposte in modo più diretto comprendono gli ecosistemi artici, le zone aride, le piccole isole in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati. In queste regioni, dove vivono le popolazioni più vulnerabili del mondo, centinaia di milioni di uomini e donne rischiano di veder peggiorare ulteriormente la loro condizione a causa del cambiamento climatico. È nei paesi poveri che il suo impatto sarà più drammatico, perché influirà non solo sul benessere degli abitanti, ma anche sulle condizioni stesse della loro sussistenza. Gli effetti della siccità e delle inondazioni sulla produzione di mais, riso e grano – i tre cereali che da migliaia di anni costituiscono il fondamento materiale della sussistenza degli esseri umani e che ancora oggi rappresentano la base della loro nutrizione – saranno avvertiti soprattutto nell’Africa sub-sahariana, nel Sud-est asiatico e nell’America centrale e meridionale, ossia nelle regioni che sono già più esposte alla fame e alla malnutrizione.
È sempre qui che l’innalzamento della temperatura globale causerà il maggior incremento della povertà, il più forte aumento della mortalità legata alle alte temperature e all’ozono, la proliferazione di epidemie di malaria e di febbre dengue, una carenza di acqua e di energia, e una cascata di ripercussioni umane derivanti da queste calamità e privazioni. Ed è nelle regioni più povere che gli effetti delle catastrofi naturali saranno più crudeli: il 90% delle vittime e il 97% dei decessi legati ai disastri ambientali sono già concentrati nei paesi in via di sviluppo. Anche nei paesi ricchi le prime comunità colpite dalle inondazioni sono i gruppi sociali più vulnerabili, che più spesso vivono nelle ex aree industriali dei fondovalle dove si concentrano i quartieri della classe lavoratrice. In generale, le vittime delle calamità naturali, siano queste inondazioni, siccità, uragani o tempeste, sono dodici volte più numerose tra le fasce più povere, che oltre a essere più vulnerabili sono anche meno dotate di mezzi di protezione in caso di emergenza. Le donne risultano inoltre più esposte degli uomini, come hanno dimostrato cicloni, tsunami e uragani dal Bangladesh a New Orleans all’Indonesia.
La disparità di esposizione ai rischi ambientali risulta particolarmente evidente se si analizzano gli effetti dell’ambiente sulla salute. Anche in questo caso, il fenomeno è riscontrabile a livello globale: i paesi più ricchi continuano a trasferire le industrie più inquinanti e le unità di stoccaggio e trattamento dei rifiuti tossici nei paesi poveri ed emergenti. I più poveri tra i poveri subiscono quindi le conseguenze dello stile di vita dei più ricchi tra i ricchi dall’altra parte del mondo: un aspetto, questo, che alcuni economisti non esitano a considerare del tutto ragionevole da un punto di vista strettamente economico. Nel 1991 Lawrence Summers, Chief Economist della Banca mondiale, scrisse in una famigerata circolare interna che poiché il costo dell’inquinamento è calcolato in base alla perdita di reddito dovuta all’aumento della morbilità e della mortalità, “una determinata quantità di inquinamento nocivo per la salute dovrebbe essere prodotta nel paese dove il costo è più basso, ovvero il paese con i salari più bassi, […] e dovremmo quindi accettarla”.
Non è difficile spiegare questa differenza di responsabilità: più aumenta il reddito, più cresce il consumo.
Oltre a influire sul benessere quotidiano, questo inquinamento nuoce gravemente alla salute delle popolazioni che vi sono esposte di continuo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, quasi 130 malattie sono direttamente collegate al degrado ambientale e agli effetti del riscaldamento globale. La commissione su inquinamento e salute 2018 della rivista The Lancet, che riunisce decine di ricercatori di diverse discipline, dopo avere analizzato gran parte della letteratura scientifica riguardante il legame tra salute e ambiente ha concluso che l’inquinamento provoca nove milioni di morti ogni anno, quindici volte più di quelli causati dalle guerre e dalle altre forme di violenza umana.
Anche in questo caso, le disuguaglianze sono evidenti: mentre nei paesi ricchi un decesso su otto può essere attribuito a fattori ambientali, nelle regioni più povere del mondo il dato raddoppia. Uno dei motivi è che in queste aree l’inquinamento dell’acqua e dell’aria legato allo stile di vita tradizionale e alla povertà rimane significativo: quasi tre miliardi di persone continuano a usare legna da ardere o carbone per riscaldarsi e per cucinare, e di conseguenza sono esposti a microparticelle. Le donne, che svolgono gran parte del lavoro domestico, sono le prime vittime. Ma l’inquinamento associato agli stili di vita dei paesi ricchi è una causa sempre più importante di malattie ambientali. Le sue principali fonti sono l’utilizzo di combustibili fossili, la produzione di elettricità, le industrie manifatturiere e chimiche, l’estrazione mineraria e la deforestazione. Anche in questo caso, le prime vittime sono le popolazioni delle regioni più povere e dei cosiddetti paesi “a reddito medio”, dove si riscontra il 92% delle patologie in questione.
Le disparità in termini di salute ambientale colpiscono soprattutto i paesi più poveri, ma non risparmiano nemmeno i gruppi sociali più vulnerabili che vivono nei paesi ricchi. Solo nell’Unione Europea, l’eccesso di mortalità riconducibile all’inquinamento dell’aria provoca quasi 800.000 decessi ogni anno, e interessa soprattutto i gruppi sociali più vulnerabili. I principali fattori da considerare per comprendere le cause sono la stratificazione sociale e territoriale. Dal punto di vista geografico questi fenomeni si concentrano in un arcipelago di luoghi inquinati, dove sorgono molte città degradate esposte all’inquinamento chimico, fabbriche attive o abbandonate, miniere, fonderie e strutture per il trattamento dei rifiuti […].
Le vittime delle calamità naturali sono dodici volte più numerose tra le fasce più povere.
Le gerarchie esistenti nel mondo del lavoro costituiscono un’ulteriore causa di iniquità ambientale. Le malattie professionali, che causano più decessi degli incidenti sul lavoro, sono legate all’esposizione a sostanze chimiche e a interferenti endocrini, diffusi in particolare nell’agricoltura, nell’industria, nelle attività di pulizia e nella lavorazione della plastica, che impegnano lavoratori poco qualificati e scarsamente retribuiti. […] In breve, la disparità dell’esposizione all’inquinamento ambientale rispecchia la struttura profonda delle disuguaglianze sociali, che si esprime nella stratificazione delle occupazioni e degli ambienti di vita. Le “zone di emarginazione sociale” sono anche “zone di emarginazione ambientale”: i più poveri, appartenenti in molti casi a gruppi etnici discriminati, sono costretti ad accettare lavori e alloggi in cui sono più esposti di altri all’inquinamento diretto e indiretto e allo sviluppo di patologie di origine ambientale che si manifestano fin dalla gestazione e dalla nascita, si protraggono per tutta la vita e spesso si trasmettono perfino di generazione in generazione.
Poiché le disgrazie non vengono mai da sole, le popolazioni più vulnerabili sono anche quelle che hanno il minore accesso ai benefici di un ambiente sano. Nei paesi più poveri, la fruizione dei beni ambientali si riduce a elementi essenziali di sussistenza, quali l’accesso alla terra, all’acqua e alla legna da ardere. Nei paesi ricchi questi beni naturali non svolgono più una funzione essenziale, essendo stati sostituiti dai combustibili fossili e dalla produzione industriale, ma contribuiscono comunque al benessere e alla salute della persona. Un alloggio adeguatamente coibentato e ventilato non solo garantisce un benessere di base, ma riduce anche il rischio di sviluppare patologie legate all’inquinamento dell’aria negli ambienti chiusi, che ogni anno provocano quattro milioni di decessi in tutto il mondo: tanti quanti quelli associati all’inquinamento atmosferico negli spazi aperti. Un’alimentazione sana riduce il rischio di obesità e di malattie cardiovascolari, responsabili ogni anno di undici milioni di morti in tutto il mondo. L’accesso regolare a spazi naturali di buona qualità contribuisce al benessere, all’interazione sociale e alla salute, in particolare quella mentale.
Anche in questo caso, però, le disuguaglianze sono drammatiche. Un reddito basso condanna i gruppi sociali più poveri a vivere in abitazioni poco isolate e scarsamente ventilate, situate in aree degradate, spesso esposte a inquinamento acustico e atmosferico. Di norma, è proprio in questi quartieri che gli spazi verdi di qualità sono più rari. I limiti economici impediscono anche l’accesso ad alimenti biologici e a detergenti o cosmetici con un minore contenuto di sostanze nocive. I quartieri svantaggiati sono anche quelli in cui si concentrano i negozi di merci a basso prezzo, che offrono solo prodotti più dannosi per l’ambiente e per la salute e alimenti di scarsa qualità nutrizionale. Relegate in periferia o nelle zone periurbane dall’aumento degli affitti, le famiglie svantaggiate sono spesso costrette a spostarsi in auto, ma non dispongono dei mezzi finanziari per acquistare veicoli poco inquinanti. Non sorprende dunque che la carbon tax introdotta in Francia dal presidente Macron, che ha inciso cinque volte di più sulle famiglie a basso reddito rispetto a quelle benestanti, abbia scatenato un’ampia mobilitazione sociale.
La disparità dell’esposizione all’inquinamento ambientale rispecchia la struttura profonda delle disuguaglianze sociali.
I provvedimenti pubblici finalizzati a contrastare questa forma di povertà si sono finora rivelati inefficaci. I meccanismi di prestito e di sussidio a sostegno della ristrutturazione degli alloggi sono raramente accessibili agli affittuari; i “bonus rottamazione” che incoraggiano a cambiare veicoli sono generalmente insufficienti per i lavoratori a basso reddito, privi di risparmi o di capacità di prestito; i processi di rinnovamento urbano e di potenziamento delle aree verdi nelle città contribuiscono spesso ad accentuare la spinta fondiaria e ad aggravare le disuguaglianze territoriali. Perfino la “semplicità volontaria”, la frugalità che si distingue dalla povertà in quanto frutto di una scelta personale, è difficilmente praticabile dai gruppi sociali svantaggiati: partecipare a un orto condiviso, impegnarsi in progetti per le città in transizione, rifornirsi nei mercati di zona, aderire a iniziative di valuta locale, a progetti di scambio di conoscenze, di bioedilizia e di coabitazione richiede tempo e risorse sociali e culturali che spesso mancano ai più poveri.
Le iniziative volte a stimolare la partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia ambientale tendono di fatto a favorire le fasce sociali più elevate, che possono contare su maggiori risorse culturali, sicurezza di sé e reti interpersonali, grazie alle quali è più facile mobilitare avvocati, media o politici locali. Tali procedure consolidano quindi, e anzi accentuano, i meccanismi di emarginazione politica delle categorie sociali più vulnerabili, che disponendo di minori strumenti per tutelarsi continuano ad assistere alla costruzione delle infrastrutture e degli impianti industriali più inquinanti proprio nei loro quartieri.
Quando dichiara che l’ecologia è la nuova lotta di classe, Bruno Latour mette in luce una dura realtà: l’attuale “modello di sviluppo” gioca interamente a favore dei più ricchi, che possono continuare ad accrescere la propria ricchezza, a godere di tutti i beni e i servizi senza alcun impedimento, anche quando danneggiano gravemente l’ambiente e la salute dei più poveri, e a garantirsi molti privilegi grazie al denaro. Potendo scegliere liberamente la propria occupazione, il luogo in cui vivere e gli hobby, si sottraggono volentieri ai danni ambientali e alle conseguenze del cambiamento climatico – e anche quando vi si trovano coinvolti, come durante gli incendi in California nell’estate del 2019, possono permettersi di ricorrere all’aiuto di vigili del fuoco privati. I più poveri, da parte loro, non possono accedere, o quasi, ai benefici offerti dall’ambiente, subiscono gli effetti dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo e non hanno modo di prepararsi alle catastrofi naturali, né di reagire quando si verificano. Sebbene la crisi climatica minacci la sopravvivenza dell’“umanità”, alcuni esseri umani sono infinitamente più esposti di altri a questo pericolo.
Un estratto da Manifesto ecosocialista. Un futuro di benessere per tutti di Paul Magnette (Treccani, 2024). Treccani è l’editore di questa rivista.